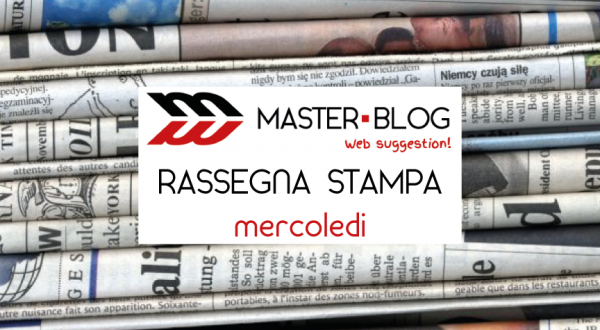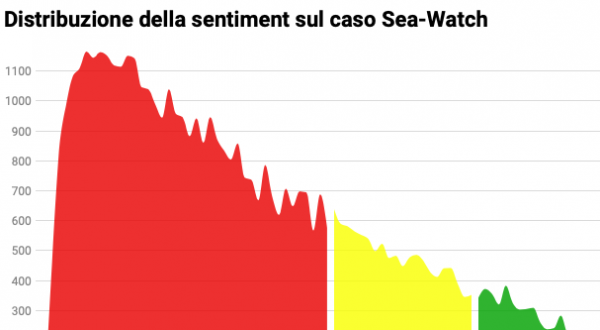di G. B. ZORZOLI
E’ stranamente passato sotto silenzio un punto dell’accordo di governo tra i popolari austriaci dell’Övp e il partito di estrema destra Fpö, che viceversa avrebbe dovuto colpire gli osservatori italiani, soprattutto se interessati ai temi dello sviluppo sostenibile. Coprire, entro il 2030, l’intero fabbisogno elettrico con le fonti di energia rinnovabili sembra obiettivo contradditorio rispetto a tutti gli altri, come i tagli fiscali e di bilancio (con conseguenti riduzioni delle prestazioni sociali), il rafforzamento della polizia e la riduzione dell’autonomia dei Länder, che sono in linea con l’orientamento ultraconservatore della nuova maggioranza. Il silenzio può essere figlio della disattenzione oppure dell’imbarazzo provocato dall’acqua santa mescolata al diavolo. In entrambi i casi però si è persa l’opportunità di scoprire che per i firmatari dell’accordo di governo la contraddizione non esiste e, per effetto di questa scoperta, di rileggere in una luce nuova le difficoltà che costellano il percorso verso lo sviluppo sostenibile.
La concezione germanica della natura
Uno dei grandi temi elaborati dalla cultura romantica germanica riguarda la concezione della natura, alla quale è riconosciuta la stessa struttura spirituale dell’uomo. Una visione destinata a influenzare il pensiero germanico anche dopo il tramonto dell’egemonia romantica: nella scienza, nella politica, come nel rispetto per la natura e per l’ambiente da parte del comune cittadino. Fino a diventare, direbbe Habermas «un’ideologia acritica». Con effetti, ai nostri occhi paradossali, se non addirittura incomprensibili. Nel 1867, il biologo e zoologo tedesco Ernst Haeckel coniò il termine “ecologia” e sotto questo nome avviò la disciplina scientifica dedicata allo studio delle interazioni fra organismo ed ambiente ma elaborò anche una concezione pseudoscientifica dell’evoluzione, di cui il Volk (popolo) tedesco incarnava lo stadio più elevato del rapporto tra uomo e natura. Così, quando Haeckel si convertì all’antisemitismo, gli apparve logico collocare gli ebrei al polo opposto dell’evoluzione, identificandoli con lo stadio del caos e dell’informe (Paolo Lombardi, Gianluca Nesi, Sangue e suolo – Le radici esoteriche del Nuovo Ordine Europeo Nazista, All’insegna del giglio, 2016). L’influenza della concezione romantica della natura sulla politica fu tale che lo stesso Hitler scrisse in Mein Kampf: «quando le persone cercano di ribellarsi contro la logica ferrea della natura, entrano in conflitto proprio con i princìpi stessi cui devono la propria esistenza di esseri umani. Le loro azioni contro la natura devono condurre alla loro rovina». Hitler e Himmler erano entrambi vegetariani rigorosi e amanti degli animali, attratti dal misticismo della natura e dalle cure omeopatiche, fortemente contrari alla vivisezione e alla crudeltà sugli animali, mentre con le camere a gas eliminavano gli ostacoli all’affermazione dello stadio più elevato del rapporto tra Volk germanico e natura. Si tratta ovviamente dei casi più aberranti di un’influenza che ha avuto e conserva effetti positivi. Lo conferma il rispetto per la natura e per l’ambiente da parte del comune cittadino in Germania, ma anche in Austria, dove misure volte a contrastare l’impatto sull’ecosistema del cambiamento climatico sono condivise da un governo ultraconservatore. La storia della politica energetico-ambientale portata avanti dai governi tedeschi dal 1990 mostra però i limiti di una strategia che riesce a sopravvivere a lungo senza sostanziali correzioni di rotta, potendo contare su un rapporto tra cittadini e natura dominato da un’ideologia acritica, che impedisce di cogliere per tempo le sue contraddizioni.
Un rapporto incestuoso
I governi tedeschi del dopoguerra non hanno sostanzialmente modificato il preesistente rapporto incestuoso con l’industria, che Wolfgang Münchau, ha definito pericoloso (È crollato il cartello tra industria e stato “Il Corriere della Sera” 25 settembre 2015). Quando il rapporto si prolunga per decenni, il decorso è sempre sostanzialmente analogo. In una prima fase, così protratta nel tempo da sembrare imperitura, avvantaggia la nazione che lo pratica, rafforzandone non solo l’economia interna, ma anche (soprattutto) la competitività e l’influenza sui mercati internazionali. Tuttavia, prima o poi con modalità diverse, i nodi vengono al pettine e, nel caso delle politiche energeticoambientali tedesche, impediscono di sfruttare al meglio il valore aggiunto derivante dall’avere avuto per tempo una visione a lungo termine, che ha identificato nella questione ambientale un’opportunità di sviluppo economico, oltre tutto connaturata alla cultura e al comune sentire dei cittadini. Dopo la prima Conferenza dell’Onu sulla protezione dell’ambiente naturale, tenutasi a Stoccolma nel 1972, la Germania assunse il ruolo di protagonista, dando la spinta alla ricerca di tecnologie in grado di ridurre l’inquinamento (desolforatori, ricombinatori catalitici), ma anche “suggerendo” normative europee sempre più stringenti. Non appena il cambiamento climatico cominciò a diventare oggetto del dibattito politico, i tedeschi decisero di replicare per questo tema la strategia già realizzata con successo per l’inquinamento, anticipando addirittura le conclusioni della Conferenza di Rio del 1992: le prime misure per la promozione delle energie rinnovabili risalgono al 7 dicembre 1990 con la Stromeinspeisungsgesetz, una legge di pochi articoli, che obbligava le imprese elettriche ad acquistare una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili a tariffe predeterminate. All’interno di tale obiettivo, i governi tedeschi preferirono scelte in grado di facilitare lo sviluppo di nuovi comparti industriali a elevato contenuto d’innovazione (eolico, fotovoltaico), al fine di conquistare la leadership a livello internazionale, scartando quelle che potevano danneggiare altri settori produttivi. Hanno utilizzato il proprio peso nelle decisioni europee per far passare al posto della carbon tax un palliativo, come l’Ets, che consente di produrre quasi il 40% dell’energia elettrica tedesca bruciando carbone e lignite, per cui “l’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020 non sarà raggiunto: basti pensare che a fine 2016 il taglio era appena del 27%. Quasi certamente il target rimarrà lontano di almeno 10 punti percentuali» (La contestabile leadership green della Germania che brucia troppo carbone, “Qualenergia.it”, 22/12/2017), mentre gli oneri per gli incentivi alle rinnovabili sono stati caricati in misura sproporzionata sui consumatori domestici, contando sulla maggiore disponibilità del tedesco medio, rispetto ai cittadini di altri paesi, a farsene carico. Di conseguenza, per una parte non trascurabile di tali consumatori il costo delle bollette energetiche assorbe più del 10% del reddito. Coerentemente con questo indirizzo, il 16 ottobre 2013 l’opposizione della Germania, per esempio, ha imposto al Consiglio dei Ministri europei dell’Ambiente il differimento di norme più stringenti per le emissioni delle automobili. Quando il veto non basta, si ricorre alla truffa, con il governo che, nella più benevola delle interpretazioni, volta gli occhi da un’altra parte, come nel Dieselgate, che ha coinvolto la Volkswagen. Alla lunga, però, la difesa cieca dell’industria tedesca non ha pagato. Le case automobilistiche stanno affannosamente recuperando i ritardi nello sviluppo dell’auto elettrica, per non perdere la propria quota del mercato cinese (la sola Volkswagen ne detiene il 20%) e probabilmente si preparano a ridimensionare la produzione dei diesel. Altrimenti non si spiegherebbe l’intervista data al quotidiano tedesco Handelsblatt, dal capo esecutivo di Volkswagen, Mathias Müller, il quale ha addirittura dichiarato che «dovremmo ridiscutere la logica e la finalità dei sussidi ai diesel. Ci dovrebbe essere una graduale diminuzione degli incentivi fiscali e le risorse andrebbero più ragionevolmente investite nella promozione di tecnologie più ecoamichevoli». Decisione che, secondo Müller, il prossimo governo di Berlino dovrebbe sostenere in sede europea. Anche l’obiettivo della leadership internazionale in tecnologie high tech per le rinnovabili si è rivelato una pia illusione, soprattutto nel caso del fotovoltaico.

Nella tabella 1, che elenca per il 2016 i primi dieci fornitori di moduli Fv, che complessivamente fanno più del 50% della produzione mondiale, otto su dieci (includendo anche Hong Kong) sono cinesi e quattro di loro occupano il primo, il secondo, il quarto e il quinto posto in classifica; la Canadian Solar, che è terza, però produce in Cina. Fuori classifica giapponesi e tedeschi, che dieci anni prima, nel 2006, detenevano circa due terzi del mercato mondiale. Complessivamente nel 2016 Cina e Taiwan avevano una quota di mercato del 68%, mentre l’Europa era al 4%. Nel 2008 tra i top ten fornitori di inverter per il fotovoltaico otto erano europei e due nordamericani. Sono bastati otto anni perché accadesse il ribaltone (tabella 2). Nel 2016, fra i top ten per i ricavi, gli europei rimasti sono solo quattro, ma anche le ditte cinesi sono quattro e due di loro occupano la prima e la seconda posizione in classifica. E sono in molti a scommettere che la scalata dei produttori d’inverter cinesi non si fermerà qui. L’errore di puntare sullo sviluppo di un’industria nazionale e non europea, l’unica in grado di garantire produzioni con un’economia di scala adeguata, rischia di riprodursi, se la Germania sosterrà l’iniziativa di una fabbrica di batterie al litio, annunciata dalla Daimler, invece di privilegiare il progetto di un gigaimpianto europeo.

Una realtà variegata
Anche se in linea di principio le strategie di contrasto al cambiamento climatico dovrebbero essere condivise dall’insieme dei cittadini, le modalità con cui Germania e Austria le stanno attuando, dimostrano che in pratica il maggiore o minore consenso dipende dalle diverse condizioni, non solo economiche e sociali, dei singoli individui e delle comunità di cui fanno parte. 32,4 milioni di persone nel 2012 sono stati costretti ad abbandonare la casa in conseguenza di disastri naturali, spesso correlati al cambiamento climatico; malgrado questi sconvolgimenti siano all’origine delle loro vicissitudini, la sete e la fame diventano i problemi che devono prioritariamente risolvere; prevalgono gli effetti, non la causa. Nei paesi emergenti la crescita economica, che tende ad aumentare il reddito medio delle famiglie, continua a rimanere la bussola che orienta il punto di vista di gran parte delle persone anche quando cominciano ad essere evidenti i conseguenti danni ambientali. Con qualche eccezione – come gli abitanti di piccole isole oceaniche, che rischiano di scomparire a breve – la preoccupazione per il cambiamento è insomma un “lusso” che possono maggiormente permettersi gli strati sociali e le popolazioni più abbienti. Mentre per contrastare altri rischi ambientali – il caso del buco dell’ozono è in tal senso è emblematico – sono state sufficienti trasformazioni tecnologico-produttive all’interno di circoscritti comparti industriali, per il cambiamento climatico occorrono trasformazioni radicali, che non investono soltanto nel suo insieme il sistema economicosociale, ma mettono in discussione anche stili di vita, quindi abitudini e culture consolidate. Inevitabilmente le policy da adottare assumono quindi connotazioni che le rendono maggiormente compatibili con movimenti, gruppi sociali, singoli individui più propensi a proporre, o almeno ad accettare, indirizzi che antepongono il futuro benessere della collettività agli egoistici interessi contingenti (un tempo si sarebbero definiti “progressisti”: la scelta del virgolettato non è casuale, data la difficoltà, oggi, di conservare all’aggettivo un inequivocabile significato). Di conseguenza, un presidente come Richard Nixon poté tranquillamente sponsorizzare nel 1970 il primo Earth Day, nato per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra, e anche successivamente presidenti e congressi americani a maggioranza repubblicana approvarono leggi per contenere l’inquinamento. Solo dopo la conferenza di Rio del 1992, che rese centrale il contrasto al cambiamento climatico, le questioni ambientali smisero di avere supporto bipartisan, discontinuità sancita dalle scelte operate durante gli otto anni della presidenza di Bush Jr. e accentuata da Trump; anche se a livello dei singoli Stati non mancano le eccezioni: dalla California, dove in entrambi gli schieramenti è dominante una cultura ambientalista, allo Utah, storicamente repubblicano, dove le rinnovabili sono diventate un business che attrae investimenti. Lo slogan “American First”, che dopo aver contribuito al successo elettorale di Trump, rimane la bussola che orienta la sua politica, trova la sua declinazione energetico-climatica nella denuncia dell’Accordo di Parigi, troppo costoso per gli americani, e la sua applicazione pratica nell’abolizione di vincoli ambientali, che favorisce gli interessi dei distretti carboniferi, dei petrolieri, delle industrie più inquinanti. In questo il nostro continente non è molto diverso dagli USA. È percorso da spinte centrifughe, minacciato dalla crescita di partiti e movimenti populisti e xenofobi, che rappresentano la punta di un iceberg, dove frustrazioni individuali e sociali si mescolano con la diffusa sensazione del distacco tra la burocrazia di Bruxelles e le esigenze reali delle popolazioni. La punta di questo iceberg è l’ostilità nei confronti di politiche energeticoclimatiche europee più incisive, da parte dei paesi dell’est facenti parte del gruppo di Visegrád (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia); ostilità che, ideologicamente giustificata dalla loro scelta sovranista, consente di difendere corposi interessi, come le miniere di carbone polacche. E, di là dalle apparenze, trova una solida sponda nella Germania. I compromessi al ribasso sulla transizione energetica, raggiunti nei più recenti Consigli europei, sono la spia della crisi, senza precedenti, che l’Unione Europea sta attraversando.
Chi spinge di più
La Cina, con motivazioni solo parzialmente diverse, ha sostituito la Germania (e di riflesso l’Europa), nella leadership di contrasto al cambiamento climatico, ruolo accentuato dopo l’elezione di Trump. In realtà, il motore primo della strategia di Pechino è l’insostenibilità dell’inquinamento urbano nella zona più industrializzata, che in larga misura coincide con la fascia orientale del paese. Il suo abbattimento passa attraverso la promozione della produzione elettrica mediante fonti rinnovabili e la penetrazione accelerata della mobilità elettrica, viste come opportunità di sviluppo delle corrispondenti filiere industriali. Già oggi la Cina ha la leadership nella produzione di batterie al litio, leadership con buone prospettive di rafforzamento. Non solo questa strategia è più completa, quindi in prospettiva più efficace di quella tedesca, ma le dimensioni della domanda interna sono tali da rendere possibile la conservazione della leadership nelle tecnologie già consolidate e il suo conseguimento nella mobilità sostenibile. La gestione autoritaria del paese, accentuata a seguito del rafforzamento della leadership di Xi Jinping, dovrebbe garantire la necessaria stabilità a questa strategia, anche se il rovescio della medaglia è l’eventualità di un cambiamento di rotta tanto brusco quanto, in mancanza di un libero dibattito, imprevedibile. Non meno rilevante è l’azione esercitata da un numero crescente di imprese. La fotografia più recente di questo fenomeno è l’elenco dei firmatari della lettera inviata ai ministri degli esteri degli Stati membri dell’Ue, in cui si chiedeva: a) di togliere qualsiasi impedimento diretto o indiretto al pieno sviluppo della contrattazione a lungo termine, che «garantisce prezzi dell’energia convenienti per le industrie e i consumatori» e favorisce la crescita della produzione con fonti rinnovabili; b) di innalzare l’obiettivo al 2030 per queste ultime dal 27% al 35%. Pochi anni fa una lettera del genere sarebbe stata sottoscritta solo da associazioni o da imprese interessate al settore delle rinnovabili. Oggi a promuoverla, insieme alle principali associazioni europee per le rinnovabili elettriche e al World Business Council for Sustainable Development, è anche RE100, un’iniziativa cui aderiscono 119 imprese del calibro di Ikea, Axa, Bank of America, British Telecom, Coca Cola, solo per citare alcuni nomi noti a tutti. Inoltre, a firmare la lettera accanto a diverse utility elettriche europee, spiccano Amazon, Facebook, Google, Microsoft. Se questo può essere un nuovo indizio delle crescenti analogie tra utility elettriche europee e mondo del web (ed è abbastanza comprensibile che tra i firmatari ci siano Philips e Siemens), differente è il significato della presenza di giganti della chimica (Du Pont e Wacker), della farmaceutica (Unilever), e – incredibile dictu – di Centrica, il cui core business è il gas. Firmare una lettera può anche essere un’operazione di maquillage, ma in questo caso le richieste sono supportate da motivazioni puntuali (vantaggi per i firmatari) e da altrettanto puntuali indicazioni delle misure attuative. Aggiungiamo il caso di una oil&gas company, come Shell, che ha acquistato NewMotion, il maggiore operatore europeo per le ricariche dei veicoli elettrici, con una rete di circa 80 mila siti, e ha deciso di installarne sei rapide in 80 stazioni di rifornimento in Belgio, Francia, Olanda, Regno Unito, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia. Ricariche che rientrano nell’iniziativa per realizzarne 400, sempre rapide, entro il 2020, varata da case automobilistiche prevalentemente tedesche (Bmw, Daimler, Volkswagen, Ford), cui Shell ha aderito. La positività di questo cambiamento, che continua a diffondersi, non deve però oscurare la percezione dei suoi limiti. È importante che un numero crescente di aziende consideri il contrasto al cambiamento climatico, un’opportunità senza alternative per il proprio sviluppo a lungo termine. Tuttavia, il percorso da seguire nella fase di transizione deve fare i conti con la necessità di remunerare gli investimenti precedenti e con la velocità con cui il mercato è disponibile ad accettare offerte di beni o servizi diversi da quelli tradizionali. I tempi delle trasformazioni aziendali possono quindi essere inadeguati rispetto all’obiettivo minimo di una crescita della temperatura globale inferiore a due gradi.
Trump dopo Trump
Dei due coprotagonisti dell’Accordo di Parigi uno ha cambiato casacca. È illusorio pensare che la scomparsa dalla scena di Trump, magari in anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato, possa automaticamente ripristinare la situazione ex-ante. Non è per nulla scontato che con lui sparisca anche il trumpismo, il cui «prostrarsi alla celebrità e all’indice di gradimento e ripudio dell’esperienza e della competenza ha infettato la nostra società civile»; non solo in USA. Quanto denunciato da Thomas Chatterton Williams sul New York Times del 9 gennaio scorso è una delle modalità con cui anche altrove si manifesta la diffusa ribellione a situazioni di insopportabili diseguaglianze economiche e sociali, modalità che rappresentano la versione aggiornata al ventunesimo secolo (definita populismo o sovranismo) delle antiche jacqueries contadine: prive di concrete proposte alternative, si limitavano a distruggere i registri catastali o fiscali, a danneggiare persone e cose, identificate come il Nemico. È una situazione che costringe i sostenitori della green society a vedere un prezioso alleato nella più grande e potente dittatura oggi esistente e un nemico nel governo della maggiore democrazia mondiale. Una condizione scomoda, come peraltro il dover sostenere l’impegno delle aziende go-green, pur in presenza di scelte contingenti che contraddicono l’obiettivo strategico. Per di più, lo spostamento a destra del baricentro politico italiano rende più difficile convincere una parte rilevante dei cittadini che è necessario cambiare il modello di sviluppo, puntando in tutti i settori sulle tecnologie e sui comportamenti “green”, senza farsi automaticamente assimilare alle élite che non si preoccupano dei problemi della gente comune: élite contro cui, col voto manifestano il loro rancore. D’altronde, come amava ripetere un filosofo nato a Treviri, «hic Rhodus, hic salta». L’alternativa – sostituire un forzoso ottimismo della ragione al pessimismo di gramsciana memoria – rischia di moltiplicare le delusioni provocate dalla dura realtà dei fatti e, di conseguenza, accrescere il già troppo diffuso pessimismo della volontà.
Source: lanuovaecologia.it