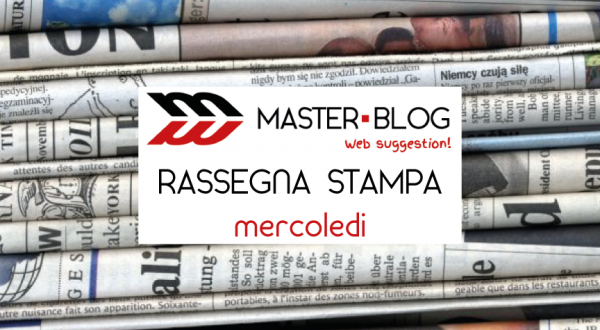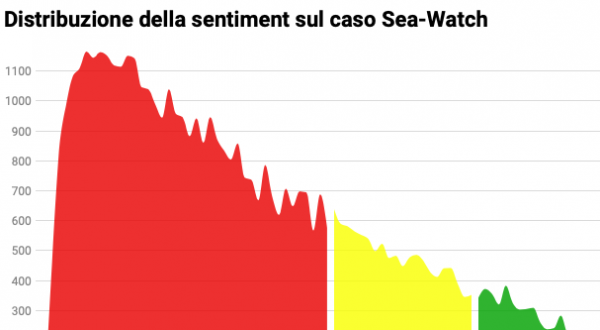Nell’aria bruciata d’agosto, si è alzata una nuvola di polvere sottile, ha invaso il piazzale, sul quale mi sono affacciato tante volte. Bastava la voce dell’altoparlante, con quegli inconfondibili accenti, per farmi sentire che ero arrivato a casa.
Adesso la telecamera scopre l’orologio, con le lancette ferme sui numeri romani: le dieci e venticinque. Un attimo, e molti destini si sono compiuti. Ascolto le frasi che sembrano monotone, ma sono sgomente, di Filippini, il cronista della TV, costretto a raccontare qualcosa che si vede, a spiegare ragioni, motivi che non si sanno: lo conosco da tanti anni, e immagino la sua pena. Dice: «Tra le vittime, c’è il corpo di una bambina».
Mi vengono in mente le pagine di una lettura giovanile, un romanzo di Thornton Wilder, «Il ponte di San Louis Rey», c’era una diligenza che passava su un viadotto, e qualcosa cedeva, precipitavano tutti nel fiume, e Wilder immaginava le loro storie, chi erano, che cosa furono.
Quell’atrio, quelle pensiline, il sottopassaggio, il caffè, le sale d’aspetto che odorano di segatura, e nei mesi invernali di bucce d’arancio, mi sono consuete da sempre: con la cassiera gentile, il ferroviere che ha la striscia azzurra sulla manica, che assegna i posti, e mentre attendiamo mi racconta le sue faccende, quelle del suocero tedesco che vuol bere e di sua moglie che dice di no, e la giornalaia, che scherza: «Ma come fa a leggere tutta questa roba?», e vorrei sapere qualcosa, che ne è stato di loro, e li penso, ma non so pregare.
Si mescolano i ricordi: le partenze dell’infanzia per le colonie marine dell’Adriatico, i primi distacchi, e c’erano ancora le locomotive che sbuffavano, i viaggi verso Porretta per andare dai nonni, e le gallerie si riempivano di faville, e bisognava chiudere i finestrini, e una mattina, incolonnato, mi avviai da qui al battaglione universitario, perché c’era la guerra.
Ritornano, con le mie, le vicende della stazione: quando, praticante al «Carlino», passavo di notte al Commissariato per sapere che cos’era capitato, perché è come stare al Grand Hotel, ma molto, molto più vasto, gente che va, gente che viene, e qualcuno su quei marciapiedi ha vissuto la sua più forte avventura: incontri con l’amore, incontri con la morte.
Passavano i treni oscurati che portavano i prigionieri dall’Africa, che gambe magre avevano gli inglesi, scendevano le tradotte di Hitler che andavano a prendere posizione nelle coste del Sud, e conobbi una Fraulein bionda in divisa da infermiera alla fontanella, riempiva borracce, ci mettemmo a parlare, chissà più come si chiamava, com’è andata a finire. Venne l’8 settembre, e davanti all’ingresso, dove in queste ore parcheggiano le autoambulanze, si piazzò un carro armato di Wehrmacht; catturavano i nostri soldati, e li portavano verso lo stadio, che allora si chiamava Littoriale. Un bersagliere cercò di scappare, ma una raffica lo fulminò; c’era una bimbetta che aveva in mano la bottiglia del latte, le scivolò via, e sull’asfalto rimase, con quell’uomo dalle braccia spalancate, una chiazza biancastra. Cominciarono le incursioni dei «liberators», e volevano sganciare su quei binari lucidi che univano ancora in qualche modo l’Italia, ma colpirono gli alberghi di fronte, qualche scambio, i palazzi attorno, le bombe caddero dappertutto, e vidi una signora con gli occhialetti d’oro, immobile, composta, seduta su un taxi, teneva accanto una bambola, pareva che dormisse, e l’autista aveva la testa abbandonata sul volante.
«Stazione di Bologna», dice una voce che sa di Lambrusco e di nebbia, di calure e di stoppie, di passione per la libertà e per la vita, quando un convoglio frena, quando un locomotore si avvia. Per i viaggiatori è un riferimento, per me un’emozione. Ecco perché mi pesa scrivere queste righe, non è vero che il mestiere ti libera dalla tristezza e dalla collera, in quella facciata devastata dallo scoppio io ritrovo tanti capitoli dell’esistenza dei mici.
«Stazione di Bologna»: quante trame sono cominciate e si sono chiuse sotto queste arcate di ferro. Quanti sono stati uccisi dallo scoppio, o travolti dalle macerie: cinquanta, sessanta, chissà? Credere al destino, una caldaia che esplode, un controllo che non funziona, una macchina che impazzisce, qualcuno che ha sbagliato, Dio che si vendica della nostra miseria, e anche l’innocente paga? Anche quei ragazzi nati in Germania che erano passati di qui per una vacanza felice, ed attesa, il premio ai buoni studi o al lavoro, una promessa mantenuta, un sogno poetico realizzato: «Kennst Du das Land, wo die Zitronen bluhen?», lo conosci questo bellissimo e tremendo Paese dove fioriscono i limoni e gli aranci, i rapimenti e gli attentati, la cortesia e il delitto, dovevano pagare anche loro? Forse era meglio vagheggiarlo nella fantasia. Ci sono genitori che cercano i figli; dov’erano diretti? Perché si sono fermati qui? Da quanto tempo favoleggiavano questa trasferta? E le signorine del telefono, già, che cosa è successo alle ragazze dal grembiule nero che stavano dietro il banco dell’interurbana: chi era in servizio? Qualcuna aveva saltato il turno? Che cosa gioca il caso?
Poi, l’altra ipotesi, quella dello sconosciuto che deposita la scatola di latta, che lascia tra le valigie o abbandonata in un angolo, magari per celebrare un anniversario che ha un nome tetro, «Italicus», perché vuol dire strage e un tempo «Italicus» significava il duomo di Bolsena, le sirene dei mari siciliani, i pini di Roma, il sorriso delle donne, l’ospitalità, il gusto di vivere di un popolo. Non mi pare possibile, perché sarebbe scattato l’inizio di un incubo, la fine di un’illusione, perché fin lì, pensavamo, non sarebbero mai arrivati.
«Stazione di Bologna», come un appuntamento con la distruzione, non come una tappa per una vacanza felice, per un incontro atteso, per una ragione quotidiana: gli affari, i commerci, le visite, lo svago. Come si fa ad ammazzare quelle turiste straniere, grosse e lentigginose, che vedono in ognuno di noi un discendente di Romeo, un cugino di Caruso, un eroe del melodramma e della leggenda, che si inebriano di cattivi moscati e di sole, di brutte canzoni? Come si fa ad ammazzare quei compaesani piccoli e neri, che emigrano per il pane e si fermano per comperare un piatto di lasagne, che consumano seduti sulle borse di plastica? Come si fa ad ammazzare quei bambini in sandali e in canottiera che aspettano impazienti, nella calura devastante, la coca cola e il panino e non sanno che nel sotterraneo, non lo sa nessuno, c’è un orologio che scandisce in quei minuti la loro sorte?
Vorrei vedere che cosa contengono quei portafogli abbandonati su un tavolo all’istituto di medicina legale: non tanto i soldi, di sicuro, patenti, anche dei santini, una lettera ripiegata e consumata, delle fotografie di facce qualunque, di quelle che si vedono esposte nelle vetrine degli «studi» di provincia: facce anonime, facce umane, facce da tutti i giorni. Dicono i versi di un vero poeta, che è nato da queste parti e si chiama Tonino Guerra: «A me la morte / mi fa morire di paura / perché morendo si lasciano troppe cose che poi non si vedranno mai più: / gli amici, quelli della famiglia, i fiori / dei viali che hanno quell’odore / e tutta la gente che ho incontrato / anche una volta sola». Sono facce che testimoniano questa angoscia, ma nessuno ha potuto salvarle.
«Stazione di Bologna». D’ora in poi non ascolteremo più l’annuncio con i sentimenti di una volta; evocava qualcosa di allegro e di epicureo, tetti rossi e mura antiche, civiltà dei libri, senso di giustizia, ironia, rispetto degli altri, massi, anche la tavola e il letto, il culto del Cielo e il culto per le buone cose della Terra.
Ora, ha sapore di agguato e di tritolo. Perché il mondo è cambiato e in peggio: i figli degli anarchici emiliani li battezzavano Fiero e Ordigno, quelli dei repubblicani Ellero e Mentana, quelli dei socialisti Oriente e Vindice, quelli dei fascisti Ardito e Dalmazia, una gli insegnavano a discutere a mensa imbandita. Si picchiavano anche, si sparavano, talvolta, ma il loro ideale era pulito e non contemplava l’agguato: Caino ed Erode non figuravano tra i loro maestri.
«Stazione di Bologna»: si può anche partire, per un viaggio senza ritorno.
Enzo Biagi, 2 agosto 1980
Quest’anno, in occasione del 37° anniversario, ottantacinque narratori racconteranno le loro storie da ottantacinque palcoscenici naturali distribuiti in tutta la città di Bologna.
Il progetto, voluto dall’Associazione dei familiari delle vittime e dall’Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna, si chiama Cantiere 2 agosto e avrà come protagonisti cittadini volontari che, coadiuvati dalla consulenza storica di Cinzia Venturoli e dal lavoro registico di Matteo Belli, si sono adoperati in questi mesi nella ricerca, nello studio e nella scrittura della storia di una vittima.
Dodici in totale i percorsi di cui il primo all’interno della stazione di Bologna, fra atrio centrale, marciapiede del binario uno, sala d’attesa e Piazzale Ovest.
Dalle 11:00 alle 23:00 ciascun narratore racconterà la storia della propria vittima per dodici volte, iniziando sempre allo stesso minuto di ogni ora.
Una grande polifonia urbana per dare vita al ricordo di chi non c’è più, ma anche una grande esperienza d’incontro pubblico in cui chi narra si fa testimone di un evento cruciale di conoscenza del passato, in rapporto a uno spazio, a un luogo e al tempo presente.