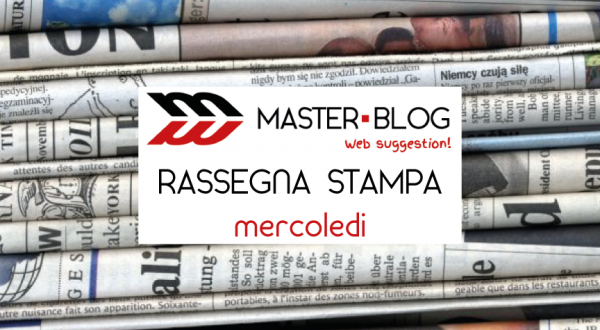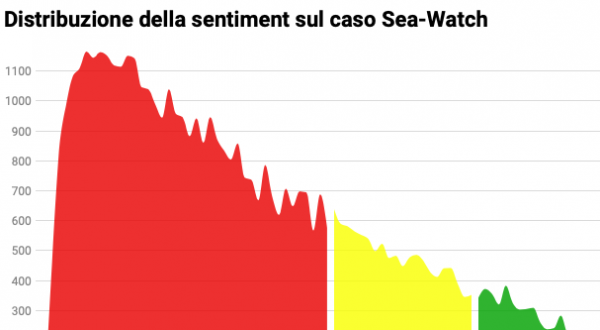Più mi guardo intorno, più mi sembra evidente che la causa principale d’infelicità tra i miei coetanei sia il lavoro. Non è così stupefacente, vero? Il lavoro non si trova (la disoccupazione giovanile è ancora al 40%), o si trova ma è precario (57% dei giovani lavoratori), o si trova ma è mal pagato (la media è tra gli 800 e i 1000 euro per gli specializzati), o è fisso ma sottoposto a regimi orari scellerati. Il lavoro è la prima cosa di cui si parla tra amici, e se si incontra qualcuno che non si vedeva da tempo non gli si chiede “che lavoro fai?” ma “lavori?”.
Essere giovani e soddisfatti del proprio lavoro, in Italia, pare così raro da suscitare, almeno in me, uno strano pudore. Passata in mezzo, come molti, ad anni di difficoltà e di incertezze, prima di parlare del mio lavoro attuale mi faccio domande del tipo: “se dico che mi trovo bene sembrerò insensibile?”, “se dico che mi piace sembrerà che me la tiri?”. Ora che ci penso, il problema del lavoro ha reso impossibile lamentarsi del proprio (“il mio capo mi telefona il sabato sera” “ringrazia che tu almeno lavori!”) e se volete la mia opinione, lamentarsi del lavoro dovrebbe essere un diritto inalienabile del cittadino. Il punto, comunque, è che l’insoddisfazione lavorativa causa depressione, è inutile negarlo. Storicamente, l’aumento dei suicidi è sempre andato di pari passo a quello della disoccupazione.
Senza toccare questi estremi, resta il fatto che sentirci appagate dalla nostra vita professionale è difficile, invidiamo “il successo” – vero o immaginato – delle altre, ci sentiamo in ritardo sui tempi, senza un posto nella società, senza talento – in poche parole, senza valore.
Giudicare il proprio valore in base ai traguardi professionali, però, è sbagliato.
Lo so, lo so, è difficile non farlo, ma è così. Ce lo ricorda Emily Asfahani Smith, che nel suo libro The Power of Meaning: Crafting a Life That Matters analizza la nostra ossessione per un’idea ben precisa di felicità, che è legata al successo. E il successo, come emerge dalle interviste raccolte da Smith, è legato soprattutto ai risultati concreti, in particolare educativi e lavorativi. È indispensabile, quindi, ripensare all’idea del successo.
Scrivere il mio libro mi ha insegnato che essere una persona di successo non riguarda i traguardi professionali o avere più giocattoli. Riguarda l’essere giusti, saggi, generosi. Le mie ricerche mostrano che coltivare queste qualità porta le persone a un senso di appagamento più profondo e duraturo, che le aiuta a risolvere i conflitti interiori e prepararsi alla morte in pace.
Smith si è avvalsa nelle sue ricerche soprattutto del lavoro di Erik Erikson, il famoso psicologo che ha individuato otto tappe dello sviluppo psicosociale dell’individuo. Secondo Erikson, ogni fase della vita corrisponde a un conflitto di tipo psicosociale che va superato per accedere alla fase successiva e realizzarsi infine come essere umano. Nel caso dell’età adulta, la sfida è quella di non cedere alla stagnazione, cioè l’egoismo e l’autoassorbimento che ci portano a valutare il nostro valore solo in base a quello che otteniamo e ai riconoscimenti altrui. Il traguardo da raggiungere, invece, è la generatività, cioè la capacità creativa e produttiva, unita alla consapevolezza che il mondo non ruota intorno a noi e alla nostra soddisfazione. Quello che conta davvero, piuttosto, è rendersi utili agli altri, in particolare alle generazioni successive: insegnare il nostro mestiere, trasmettere le nostre conoscenze, aiutare gli altri a raggiungere i loro obbiettivi e ad esprimere il loro potenziale. Senza questa capacità restiamo poco più che adolescenti, e anche crescere figli di sangue rischia di trasformarsi in un atto egoistico.
Smith declina il pensiero di Erikson alla cultura del successo, e ci invita a considerare il nostro valore non in base a quello che otteniamo sul lavoro, ma a quello che riusciamo a dare agli altri nelle nostre interazioni quotidiane.
Sì, direte voi, ma il lavoro è importante. Sì che lo è, ma non è l’unica cosa importante, e certamente non deve essere l’unica sulla cui base giudichiamo la nostra soddisfazione e il nostro valore. Non ci sono altri campi in cui possiamo essere creativi e produttivi? Non ci sono altre esperienze che ci rendono felici? Non ci sono altre persone per cui siamo indispensabili? Queste cose non vanno svalutate, ma valorizzate. Anche perché, crescendo, ci si rende conto che non è vero che basta volere qualcosa per ottenerla. La cultura del successo ci ha convinti che tutti abbiamo il diritto e il dovere di realizzare i nostri obbiettivi, ma la realtà è che non sempre è possibile. Questo però non significa che la nostra vita non abbia valore, perché il valore non sta nell’ottenere, ma nel sentirsi parte di qualcosa.
Il successo non è una questione di vincere o perdere, ma di raggiungere un senso di completezza. Se ce lo mettiamo in testa, anche i problemi lavorativi riprenderanno la loro giusta – importante, ma più schiacciante – dimensione.
Source: freedamedia.it