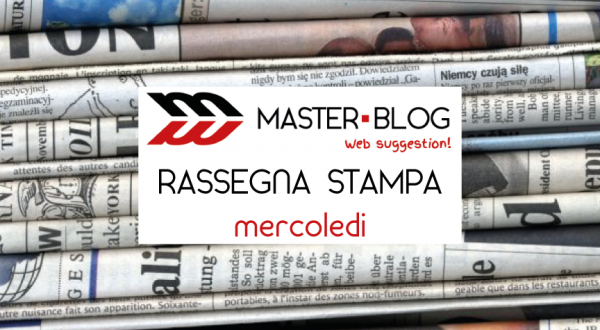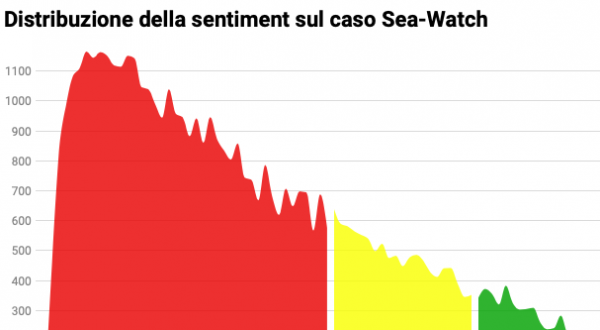Quando penso ad Alda Merini mi viene in mente una collana di perle annodata da un lato, un muro pieno di parole scritte con il rossetto, delle sigarette, i Navigli di Milano. Poi mi viene in mente una signora non tanto alta, una giacca pesante e un seno nudo. E quella volta che ancora non sapevo chi fosse, ma l’ho incontrata, poco prima che morisse.
Non è facile imbrigliare Alda Merini in una sola definizione: una poetessa che buttava via le sue poesie, una donna devota, una mistica, una ragazza giovane, un’amante, una moglie, una madre e una (non) folle. La pazza della porta accanto – diceva lei – o, ancora, usando sempre le sue stesse parole, una piccola ape furibonda.

Indiscutibilmente una delle delle più grandi voci italiane del Novecento, Alda Merini nasce a Milano, in viale Papiniano, il 21 Marzo del 1931, a primavera. Nasce da una famiglia modesta ed è la seconda di tre figli, Anna ed Ezio, ai quali non sembra essere particolarmente legata. Della sua infanzia non si sa molto, a parte qualche nota autobiografica in cui racconta di essere stata una ragazzina sensibile, ma molto malinconica, poco compresa e brava a scuola, perché “lo studio fu sempre una mia parte vitale.” Terminate le scuole dell’obbligo Alda prova a entrare al Liceo Manzoni, ma non ci riesce perché non supera la prova di italiano. È in questo stesso periodo, all’età di circa 15 anni, che si dedica allo studio del pianoforte, apprendendo il senso del ritmo e della metrica, e inizia a scrivere le sue prime poesie. Non solo, ma è sempre in questo stesso periodo che iniziano a farle visita quelle che lei stessa, poi, definirà “le ombre della mia mente.” Quella malinconia che fin da piccola la aveva contraddistinta diventa ora più intensa, un dolore sconosciuto, a cui Alda non riesce a dare ancora un nome. Eppure, nonostante tutto, non si sente sbagliata, non ritiene di essere malata. Ancora molto giovane viene internata per un mese nella Clinica di Villa Turro, a Milano, e le viene diagnosticato un disturbo bipolare; un’etichetta, quella di “malata di mente” che scandirà tutte le fasi della sua vita successiva e contro cui combatterà incessantemente.
Sono nata il ventuno a primavera
ma non sapevo che nascere folle,
aprire le zolle
potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve
vede piovere sulle erbe,
sui grossi frumenti gentili
e piange sempre la sera.
Forse è la sua preghiera
Tornata a casa Alda continua a scrivere e inizia anche a far leggere le sue poesie. Viene notata da personalità come Quasimodo, Montale e Pasolini, da cui si sente capita e accettata, ma finisce per sposare un uomo che non parlava esattamente il suo stesso linguaggio. Stiamo parlando di Ettore Carniti, proprietario di diverse panetterie di Milano, con poca passione per le parole e molta per l’alcol.
Spesso Ettore torna a casa la sera ubriaco e la picchia, ma lei lo ama, di un amore devoto e profondo e si mette in attesa. Attende di stare meglio, attende che il loro amore vinca su tutto il resto, e durante questa attesa continua a scrivere, le sue prime poesie vengono pubblicate e viene internata per un periodo molto lungo, che va all’incirca dal 1965 al 1972, nell’ospedale psichiatrico di Milano, il Paolo Pini. Nell’arco di diverse interviste Alda racconterà che il suo non fu un ricovero coatto, ma che, anzi, furono lei e il marito ad accettarlo, convinti che avrebbe dato dei risultati positivi. Internata per 7 anni, durante i quali torna a casa saltuariamente e fa 4 figli, Alda vive quell’esperienza terrificante e al tempo stesso incredibilmente umana che è il manicomio. Un’esperienza che aprirà ai suoi occhi le crepe dell’esistenza, mostrandola per quello che realmente è.
Quando ci mettevano il cappio al collo e ci buttavano sulle brandine nude insieme a cocci immondi di bottiglie per favorire l’autoannientamento, allora sulle fronti madide compariva il sudore degli orti sacri, degli orti maledetti degli ulivi. Quando gli infermieri bastardi ci sollevavano le gonne putride e ghignavano, ghignavano verde, era in quel momento preciso che volevamo la lapidazione. Quando venivamo inchiodati in un cesso per esser sottoposti alla Cerletti, era in quel momento che la Gestapo vinceva e i nostri maledettissimi corpi non osavano sferrare pugni a destra e a manca per la resurrezione degli uomini.
Da questi anni, e poi da quelli successivi che la vedranno di nuovo internata, anche se per periodi più brevi, nasce uno dei suoi lavori più celebri, Terra Santa, pubblicato nel 1984, in cui racconta del manicomio. Racconta di quel mistero che è il dolore della mente, che in fondo accomuna tutti, perché il dolore non è altro che “la sorpresa di non conoscerci”. È illogico, non segue nessuna regola e per questo fa paura, terrorizza. Come rispondere a qualcosa di così poco governabile e terrorizzante? Con la spersonalizzazione dei “malati” (che, appunto, malati non sono), con il loro annientamento, con gli elettroshock, con i divieti: in manicomio non si può amare, non si può fare l’amore, non si può fumare, non si può vivere. Nei suoi libri, nelle sue interviste, nelle sue poesie Alda Merini racconta di un tradimento, di una una promessa di guarigione che si trasforma in tortura perché l’unico modo per curare qualcuno che soffre è attraverso l’amore. “L’uomo, mio simile mi ha tradito. Mi ha messo in prigione. Chi sei tu per giudicarmi, per mettermi in prigione?” Uno dei pochi da cui Alda non si sentirà mai tradita sarà Franco Basaglia, fondatore della nuova concezione moderna della salute mentale (che forse fatica ancora troppo a prendere piede) che con la legge n.180 modificò nel 1978 l’ordinamento degli ospedali psichiatrici in Italia. A lui, alla sua delicatezza, alla sua attività, svolta a partire da Trieste, e a quel nuovo modo intendere la follia, dedicherà dei versi:
Il vento, la bora, le navi che vanno via
il sogno di questa notte
e tu
eterno soccorritore
che da dietro le piante onnivore
guardavi in età giovanile
i nostri baci assurdi
alle vecchie cortecce della vita.
Come eravamo innamorati, noi,
laggiù nei manicomi
quando speravamo un giorno
di tornare a fiorire
ma la cosa più inaudita, credi,
è stato quando abbiamo scoperto
che non eravamo mai stati malati.
Intanto nel 1983 il marito, Ettore Carniti, muore, lasciandola in una situazione economica molto complicata. Conosce un altro uomo, di 30 anni più grande di lei: il medico Michele Pierri. I due si sposano, nonostante la differenza di età e nonostante la famiglia di lui non fosse assolutamente d’accordo. Si trasferiscono a Taranto, dove lei vive finché le condizioni di salute di Michele non si aggravano e i suoi famigliari non la cacciano di casa. Di nuovo viene internata e poi, una volta uscita dal manicomio, decide di tornare a Milano, nella sua amata casa sui Navigli. Il ritorno a Milano le fa bene: compone moltissimo, in ogni momento. E lo fa perché è il suo modo di affrontare la vita, di attraversarla, di rapportarsi agli altri. L’esperienza del manicomio ha distrutto la sua fiducia nel prossimo; ora Alda preferisce stare sola, ma vuole comunque avere a che fare con le persone, vuole che gli altri la amino, e allora continua a farlo attraverso la poesia. Non scrive sempre, perché – diceva – “fare poesia non è scrivere, è pensare. Poi che la parola sia scritta o non sia scritta non ha nessun valore.” Ciò che conta per lei è prima di tutto la parola, con la quale ha un rapporto intimo, immediato, pratico, quasi corporeo. I suoi versi nascono direttamente dalle esperienze vissute, sono parole che sgorgano da ferite e sono prima di tutto orali. Li detta agli amici, spesso per telefono. Le sue poesie sono davvero un mezzo di sopravvivenza, quasi fisica, al punto tale che una volta composte vengono spesso buttate via, perché sono come “scorie”. Anche per questo, per la caoticità della “scrittura” è stato spesso difficile ordinarle cronologicamente.
O donne povere e sole,
violentate da chi
non vi conosce.
Donne che avete mani
sull’infanzia,
esultanti segreti
d’amore tenete conto
che la vostra voracità
naturale non
sarà mai saziata.
Mangerete polvere,
cercherete d’impazzire
e non ci riuscirete,
avrete sempre il filo
della ragione che vi
taglierà in due.
Ma da queste profonde
ferite usciranno
farfalle libere.
Se insisto tanto su questo aspetto corporeo non è un caso. Alda Merini aveva un approccio mistico alla vita, al mondo, ai suoi testi. Un approccio quasi erotico, di continuo scambio fisico e simbolico tra sé e il mondo.
È in questo periodo così prolifico che il suo talento viene ufficialmente e universalmente riconosciuto, ancor più di prima. Riceve premi, lauree honoris causa, inizia a guadagnare e a poter vivere della sua poesia. Ma i soldi non le interessano. Trascorre comunque la maggior parte dei suoi giorni vivendo da clochard. Per un breve periodo va a vivere all’Hotel Certosa, dove resta finché non finisce tutti i soldi che aveva, donati però per la maggior parte ai barboni. Non per carità retorica, ma perché era questo il suo modo di vivere: lei, che aveva capito e vissuto l’esperienza comune del dolore, non sentiva il bisogno di indagarne le ragioni. Lei quel dolore lo indossava come “un vestito incandescente” e ci camminava per strada, con l’unico obiettivo di far sentire gli altri meno soli in questa esperienza.
Muore il 1° novembre 2009, a causa di un tumore. In Diario di una diversa aveva scritto “io la vita l’ho goduta perchè mi piace anche l’inferno della vita, e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perchè l’ho pagata cara.”
L’anno successivo il Comune di Milano ha affisso fuori dalla sua Casa di Ripa di Porta Ticinese un cartello con su scritto “Ad Alda Merini. Nell’intimità dei misteri del mondo.”
Source: freedamedia.it