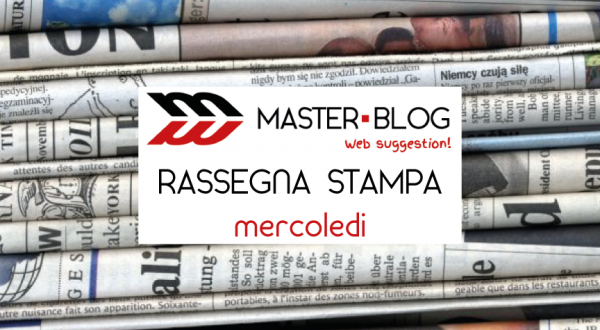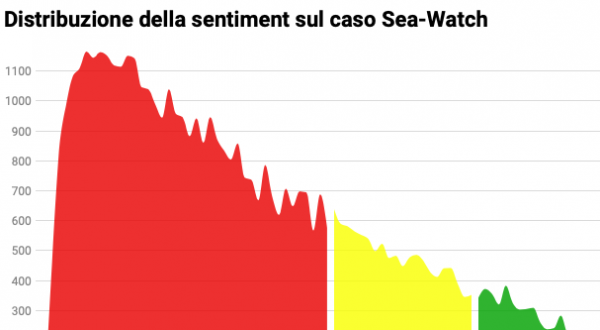Quando ero piccola una delle fissazioni di mia madre erano i cappelli. O meglio, non aveva una passione per i cappelli in sé, ma le piaceva da morire comprarli per me, in quel meraviglioso momento della vita (per lei) in cui non avevo alcun potere decisionale su cosa indossare. Era profondamente convinta che io dovessi indossare cappelli, nella fattispecie delle scomodissime cuffiette in velluto (che non mi facevano sentire esattamente a mio agio) e molteplici versioni di basco, con pon pon o senza, rigorosamente di lana (che pizzicavano tantissimo). E quando arrivava Carnevale, perché non sbizzarrirsi con un bel sombrero? Si può mai perdere questa incredibile chance? Certo che no. Ma, nonostante l’avermi travestita da messicana, a Febbraio, abbia lasciato in me un segno indelebile, mia madre ha avuto il merito di farmi scoprire il mio cappello preferito: la coppola. Pratica e comoda, ne ho avute di tutti i tipi: da quelle un po’ molli alle super rigide.
Ho passato elementari e medie con un’affezione tutta particolare a quel berretto di stoffa, solitamente tra i colori del verde e del marrone: era un vecchio cappello di mio padre e questo mi faceva sentire assolutamente speciale e forse anche un po’ adulta. Poi, non ricordo neanche come, ho smesso di indossarla: forse avevo capito che non andava particolarmente di moda e sono così passata ai classici cappellini con la visiera, “alla jovanotti“, giusto per non prendere troppo sole in testa al mare o mentre facevo sport. Ma si vede che non mi convincevano e presto ho smesso anche con quelli.
Ecco che ho abbandonato l’abitudine di portare cappelli. Ma ho continuato a osservarli da lontano, a indugiare sui dettagli di storie che ne raccontavano gli straordinari poteri o che caratterizzavano chi li portava – dal cilindro del cappellaio matto, al cappello parlante di Harry Potter.
Ho coltivato nel tempo la malinconia di quando uscivo sempre con il mio berretto e di quell’aria più spavalda che mi dava. Ma non c’era niente da fare: invece di darmi sicurezza, moltiplicava i miei dubbi. “Quante storie per un cappello, mettitelo e basta!” mi diceva sempre mio fratello, se lo interrogavo su quanto potessi sembrare ridicola con indosso la mia vecchia coppola. Vaglielo a spiegare che non era solo un cappello, ma un oggetto che ti completa, che chiude il cerchio, l’altro capo della mia identità, l’equivalente aereo delle scarpe – se loro mi davano l’andatura, il cappello guardava nella mia testa e mi consigliava, mi dava un’aria di volta in volta, diversa.
Conosciamo grandi condottieri che indossavano fieramente i loro cappelli, come quello a due punte di Napoleone, e se diamo un occhio alla storia del basco, vediamo che anche in questo caso, è stata la scelta di grandi personalità come Rembrandt, Picasso, Che Guevara ed Hemingway.

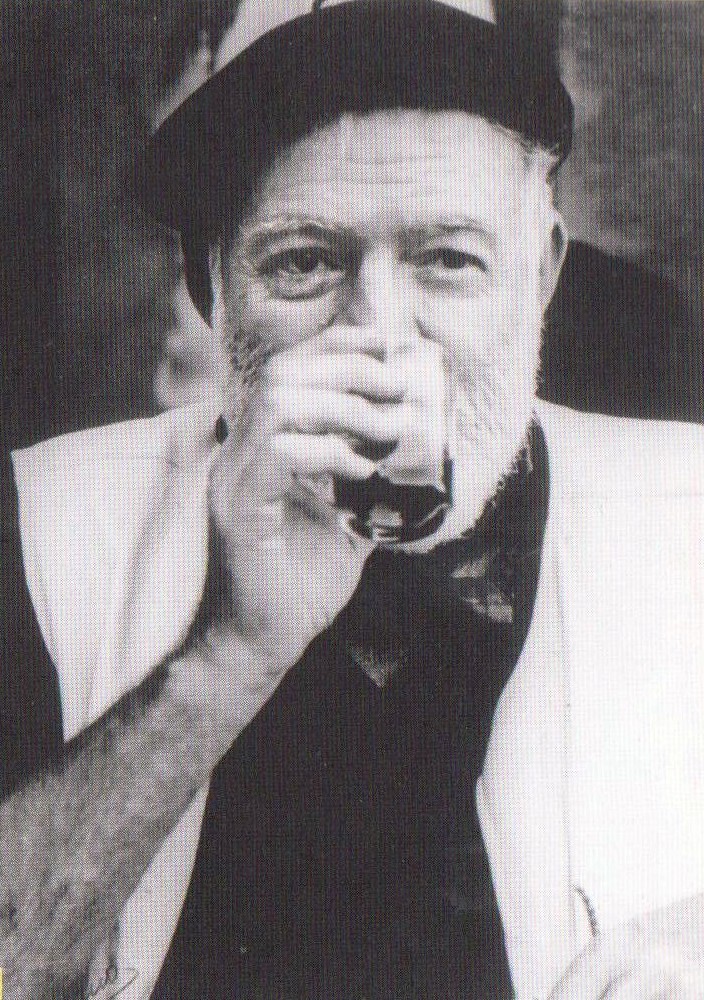
Li abbiamo ammirati sul capo di artisti, condottieri e anche i miti del cinema: penso al cappello di Jack Sparrow, di Indiana Jones, di Robin Hood; quello a tesa lunga di Audrey Hepburn, la bombetta di Charlie Chaplin, il basco di Faye Dunaway, il borsalino di Humphrey Bogart in Casablanca e lo splendido turbante che indossa Lana Turner nella sua prima apparizione ne Il postino suona sempre due volte.


E ancora il deerstalker di Sherlock Holmes e il cappello a tre piume di Cyrano de Bergerac; il borsalino nero fedora di Michael Jackson e quelli iconici indossati da John Wayne nei suoi film western. Per non parlare poi dei cappelli dei Blues Brothers e del mitico Fantozzi.


Vi è testimonianza di cappelli in ogni civiltà antica, e se prima aveva la funzione di proteggere la testa, nel tempo ha assunto un significato simbolico: sono cambiati i materiali, le forme e colori, e sono rientrati nell’abbigliamento di funzioni religiose e militari. Per le donne, l’evoluzione del cappello andava spesso di pari passo al modo di acconciare i capelli: per i volumi del settecento e ottocento, ad esempio, occorrevano cappelli molto grandi e con dei lunghi nastri (o con i famosi spilloni) per fissarli meglio, ma non sono mancate neanche le cuffiette più minimal.

Simbolo di comando, potere ed eccentricità, sono un elemento di comunicazione e un iconico dettaglio di stile. Vogliamo parlare dei cappelli della regina Elisabetta II?

Non sono solo cappelli dunque, ma schegge di personalità, forme di un certo carattere. Un carattere formato da tante sfaccettature come quello di mia nonna, che ho riscoperto attraverso la sua collezione di cappelli, ritrovata per caso in un angolo nascosto in cantina, molti anni dopo la sua morte. Tre cappelliere che custodivano tutti i suoi amati cappelli: da quelli per andare a dormire, lunghi, di lana, fino a quelli decorati con piume d’uccello e retine finissime. Cuffiette e turbanti dai colori sgargianti, tutto un universo che non conoscevo e che mi ha portato a fantasticare su quei lati del suo carattere che non ho avuto l’occasione di scoprire. Quante avventure deve aver vissuto, che non conoscevo, con quelle meravigliose creazioni! Poi certo, li ho subito rimessi via pensando “questi ormai, chi se li mette più”. Ma nei giorni a seguire non potevo non fermarmi a immaginare quell’incredibile arsenale di storie, custodite nelle tre cappelliere. E allora tutte le fisime sul “mi starà bene, mi guarderanno tutti, oddio non ho la faccia giusta, aiuto, aiutatemiadireaiuto” sono svanite. La cosa più importante era farli rivivere e pensare che dopotutto, erano solo cappelli. La differenza che fa agli altri è sempre minore di quello che pensiamo, mentre per noi anche una cosa così banale come indossare un cappello, può voler dire tantissimo. Mai successo di fare affidamento su un oggetto (facilmente un indumento) per dare una scossa al proprio coraggio, per credere, aggrappandosi a un dettaglio, di vivere una piccola avventura? Forse sembra ridicolo (e penso al cappello del giullare) ma in fondo non importa. Ho ripreso lentamente, quasi in segreto, a indossare alcuni di quei cappelli (per altri ho bisogno di tempo), che sorridono alla mia immaginazione e forse anche alla mia vanità. Inizialmente la sensazione è quella di andare in giro travestita – più che vestita – ma ormai non ci faccio quasi più caso.
In una bellissima Ted Conference, la drammaturga e attrice Eve Ensler (che ha scritto i Monologhi della vagina), ha raccontato di come per un certo periodo di tempo fosse stata “una testa vagante” e per questo motivo, per anni, ha indossato cappelli. Ho pensato che forse, per me, è successo esattamente il contrario. Per liberare un po’ la mente, avevo bisogno di indossare cappelli stravaganti, uscire un po’ dalla cosiddetta “normalità” e andare in giro ridendo un po’ della mia testa. E sembra che su di me, abbia funzionato.
Source: freedamedia.it